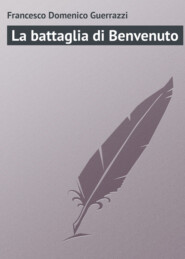
Полная версия:
La battaglia di Benvenuto
Federigo non pertanto viveva: fatto prigioniero dai Bresciani, si traveste da mendico, e ricompare a Pavia con l’onta di una disfatta sul volto. Fremeva il superbo nel doversi dir vinto: ma i casi più potenti di lui lo costringevano a mandare a Roma ambasciatori per la pace, tanto adesso da lui lealmente domandata, quanto poc’anzi perfidamente conclusa con Ezzelino padre del feroce Ezzelino da Romano, ed Anselmo padre di Buoso da Doara, a nome della Lega Lombarda. Convennero di un Congresso in Bologna; poi mutarono in Venezia, a patto che non c’intervenisse lo Imperatore se non a pace fermata. I Ministri non si accordavano; invece di pace proponevano tregua di quindici anni pel Papa e pel Re di Sicilia, di sei per la Lega Lombarda. Federigo domanda avvicinarsi al luogo del Congresso, e al punto stesso, senza nessuna risposta aspettare, lasciata Pomposa, villa nel contado di Ravenna, giunge a Chiozza. Parte dei Veneziani tumultuando chiede che sia ammesso in città; il Papa, e i Legati Siciliani sostengono doversi stare ai patti: accetti la tregua, e la ratifichi, altrimenti si allontani; se ai cittadini piacesse riceverlo, lo ricevessero, ma essi partirebbero nel punto stesso, protestando contro la manifesta infrazione del diritto delle genti. Alla fine Federigo per mezzo del Conte Enrico Dessau accetta la tregua il 6 luglio 1177. Allora mandato a prendere a Chiozza dal Senato veneziano, fu dal Doge Sebastiano Ziani condotto a grande onoranza sopra la piazza di San Marco, dove incontrato il Pontefice, secondo quello che narrano gli antichi cronisti, toltasi la porpora imperiale dalle spalle la stese per terra, e quindi prostratosi si curvò in atto di baciare il piede al Papa Alessandro, che ponendoglielo in vece sul collo esclamò: Super aspidem et basiliscum ambulavi etc. Alle quali parole Federigo rispose: Non tibi, sed Petro: – e il Papa di nuovo: Ego sum vicarius Petri. Questa istoria, comunque si veda tuttora con bellissime pitture effigiata su le pareti della Sala grande del Consiglio di Venezia, reputasi dai moderni storiografi una favola, senza però che ne abbiano esposto le cagioni, almeno per quanto mi riuscisse di poter ricercare. Passarono gli anni della tregua senza che accadesse azione degna di memoria; e già si avvicinava il tempo di riassumere le offese, allorchè Federigo, ormai disperato di fare buon frutto in Italia, e indotto dalle istanze del figlio Enrico VII a convertire la tregua in pace durevole, mandò al Congresso di Piacenza Guglielmo Vescovo di Asti, Enrico, Teodorico e Rodolfo, per trattare l’accordo. Questi convennero dei preliminari, e invitarono i deputati delle Repubbliche lombarde alla Dieta di Gostanza. Conservasi il libro della Pace di Gostanza su la fine del Codice dell’Imperatore Giustiniano, come monumento importantissimo, non pure per avere lungo tempo regolato i diritti delle genti in Italia, quanto per dimostrare la indole del Barbarossa. Costretto a cedere, vuol far sembianza di donare; e con orgoglio, che disdirebbe alla vittoria, concede cose, che appena si ricercano dai vinti. La prudenza dei Lombardi chiaramente si manifesta in questa occasione, imperciocchè, poco curando la petulanza dello stile ampolloso, guardarono ai loro interessi, e lasciarono ch’ei si sfogasse. Il proemio della Pace di Gostanza litteralmente volgarizzato dice: «La benigna ed infinita serenità della imperiale clemenza ebbe sempre in costume di reggere i popoli con larghezza di favore e di grazia, per modo, che sebbene debba, e possa con rigida severità punire i delitti, pure ama piuttosto governare l’Impero Romano con la propizia tranquillità della pace, e con pietosi affetti di misericordia chiamare la insolenza dei ribelli alla dovuta fede, ed all’ossequio di debita lealtà ec.» Dopo tanto pomposo cominciamento l’Imperatore cede tutte le Regalie, i contadi, i diritti acquistati per prescrizione, quelli di levare eserciti, afforzare le mura, rendere giustizia; annulla le confische dei beni, e le Infeudazioni in danno delle città; approva che sollevandosi qualche disputa tra lui e un popolo, il Vescovo decida; promette non dimorare tanto lungamente in una città da farle guasto. I Lombardi convengono di ricorrere ad un suo Vicario, o Podestà, per l’appello delle cause maggiori di venticinque lire; si obbligano a corrispondere del Fodero, del Mansionatico, e della Parata; patteggiano rinnuovare ogni dieci anni il giuramento di fedeltà.
Così, dopo il sagrifizio di oltre un milione di uomini in sette diverse imprese, finivano i disegni ambiziosi di Federigo in Italia. Ma quel suo spirito non poteva durare in riposo: nulla curando gli anni, ormai divenuti molti, nulla i disagi e i pericoli, appena giunse novella in Occidente che Saladino aveva preso Gerusalemme, tolta la croce, con novantamila combattenti traversò l’Ungheria, la Bulgaria, la Grecia, e giunto in Soria, mentre intende a conquistare le terre soggette al Saladino, bagnandosi nel fiume Salef ossivvero Cidno, dove anche Alessandro stette per perder la vita, miseramente annegava. Altri scrisse, che fu fatto annegare: ma la prova del delitto sta in mano di colui che può sempre punirlo. Questa è la Crociata, ch’espugnò Tolemaide, nella quale intervennero Filippo il Bornio Re di Francia, e Riccardo Plantageneto Re d’Inghilterra, insieme a moltissimi Baroni di tutta Cristianità, ed esposta con tanta sapienza di storia dal chiarissimo Gualtiero Scoti.
CAPITOLO SETTIMO. LA CASA DI SVEVIA
Ponga il cor di Blacasso alle sue labbia
L’Imperator di Roma Federigo,
Finchè conquisi n’abbia
I Milanesi, che per ogni parte
Assedio posto gli hanno,
E vive senza suo retaggio, e i suoi
Tedeschi dentro al cor sentono affanno.
Serventese del Trovatore Sordella in morte di Ser Blacasso.Sono l’uracano, il fulmine, e il terremoto, terribilissimi segni dello sdegno di Dio; ma più del terremoto, del fulmine, e dell’uracano, flagella terribile la umanità un Re scellerato. Qualora l’eterno Moderatore non lo condannasse a brevissima vita, parrebbe non voler tenere più il patto che strinse con Noè, quando promise, d’ora in avanti non avrebbe più distrutta la terra, perchè la schiatta umana cresce nella perfidia, e il pensiero della sua fanciullezza è vôlto al male.
Ma se la vita è breve, la infamia dura lunga: e noi nepoti contenderemo la memoria dei potenti colpevoli alla dimenticanza; e scenderemo nei sepolcri, e ne turberemo le ceneri. La corona che cinge quei teschii schifosi è un insulto per loro, uno scherno per noi. La spada logorata dagli anni giace al fianco di quelli senza taglio, e senza punta: – quel braccio tanto terribile non può più percuoterci… il verme lo ha vinto! e noi strappiamo impunemente ai tempi, e alla terra, quei nomi: e gli nudriamo di obbrobrio, e li tramandiamo agli anni futuri. Allorchè la mia voce sarà dimenticata, sorga una mente più calda, che ravvivi col disprezzo questa memoria di delitto; e possa il secolo che trascorre consegnarla al secolo che giunge, come un deposito che lo amico affida all’amico, onde la disperazione arda lenta lenta, a goccie infuocate, lo spirito del malvagio; e conosca, la morte essergli stata battesimo di maladizione per la vita interminabile dell’anima.
Se in alcuno dei nostri lettori si fosse suscitato un pensiero di amore per Enrico VII, che poc’anzi abbiamo veduto sollecitare il padre alla pace, sappia, queste considerazioni essere state fatte per lui. Nessuno sia così stolto da credere che un atto gentile derivi necessariamente da animo gentile. La più parte di noi pratica la virtù, perchè non fa frutto con la colpa, e commette la colpa, perchè non gli giova la virtù: nè lo spirito per questo si cambia in nulla, ch’egli rimane pur sempre tristo, o maligno, come la natura, o la educazione, ce lo ha dato. Se Enrico VII amò la pace, fu perchè il padre gli aveva promesso farselo compagno del potere, nè questo sperava conseguire, dove non avesse fine la guerra. Federigo considerando che non avrebbe mai ottenuto con le armi un dominio in Italia, tentò acquistarlo per via di pratiche, e fece tenere proposito a Guglielmo II di Napoli, santissimo Re, detto il Buono, se volesse concedere la sua zia Gostanza, figlia postuma del Re Rogiero, ad Enrico suo figlio. Guglielmo non avendo prole consente al trattato. Nel 1184 è fama che seguissero in Milano questi sponsali, sedendo su la cattedra di San Pietro Urbano III. ed è pur fama, che Enrico oltre i diritti sul Regno di Napoli ricevesse in dote centocinquanta somari carichi d’oro, di vasellame di argento, vesti, sciamiti, grisi (forse vaj), ed altre preziose masserizie. Di lì a qualche anno morto Guglielmo il Buono, sebbene il Regno cadesse a Gostanza, i Siciliani, comportando gravemente la straniera dominazione, chiamarono Re Tancredi, Conte di Lecce, e Principe di Taranto, figlio illegittimo di Rogiero Duca di Puglia. Enrico VII disposto a volere ricuperare i suoi diritti implora il soccorso dei Pisani e dei Genovesi, promettendo loro amplissimi privilegii, si avanza dal lato di Cepperano, ed occupa tutta Terra di Lavoro fino a Napoli, il quale tien fermo per Tancredi. Una terribile epidemia distrugge l’esercito tedesco, che, costretto ad abbandonare il Regno, fugge a Genova. Riccardo Conte di Acerra ricupera Terra di Lavoro. La Imperatrice Gostanza, che posando su la fede dei Salernitani soprastava a Salerno, è dai cittadini consegnata a Tancredi. Questi, come uomo di cuore magnanimo, la rimanda ad Enrico senza riscatto; della quale cortesia come fosse in séguito ricompensato, vedremo tra poco. Rogiero primogenito di Tancredi, sua consolazione e conforto, dopo avere condotto a moglie Irene, figlia d’Isacco Angelo Imperatore di Costantinopoli, moriva. Tancredi soprappreso di acerbissima doglia lo seguitava nel sepolcro, lasciando Sibilia moglie, Guglielmo, Albinia e Mandonia, figli suoi. Enrico VII, saputa la morte del valoroso Principe, cammina celerissimo contro il Regno, e per questa volta gli viene fatto di conquistarlo. La Regina Sibilia ripara co’ figli nel castello di Calatabellota, in que’ tempi stimato insuperabile. Enrico le fa proporre di uscire, e nella Contea di Lecce, prima signoria del suo marito, restituirla. Accetta la sventurata: di lì a poco, ecco come Enrico adempiva i patti promessi: Guglielmo fece abbacinare, e privare dei genitali, sì che presto se ne moriva; Sibilia, Albina e Mandonia, mandò in carcere nei Grigioni. Ora si manifesta il suo feroce talento: fatti prendere tutti coloro che avevano parteggiato per Tancredi, ordinò che sul capo loro si ponessero corone di ferro infuocate, e con chiodi roventi vi si conficcassero. Riccardo Conte di Acerra, caduto in suo potere, fu strascinato a coda di cavallo, poi appiccato pei piedi; nè mai, finchè visse quel crudele, consentì che si rimovesse dallo infame patibolo. Margarito Grande Ammiraglio ebbe gli occhi divelti, i genitali recisi. I Genovesi e i Pisani non solo delle cose promesse non soddisfece, ma ben anche della buona fede loro schernì. Poi, come se infierire contro i vivi fosse poco, volse il suo furore contro i morti. Fatti disseppellire i cadaveri di Tancredi e di Rogiero, strappò loro con rabbia la corona reale dal capo. Le sue crudeltà e rapine di tanto si aumentarono, che il Papa gli spedì un Legato per farle cessare; egli poi non pure non le cessò, ma anzi le accrebbe, e, con infinito dolore dei Palermitani, tutti i tesori dei defunti Re, i vasi di oro e di argento, le tavole, le lettiere dello stesso metallo, i panni tessuti di seta, di porpora e di oro, con infinite altre preziosità mandò in Germania. In questo lo arrivava la mano della morte: fatto odioso ai sudditi, ed alla sua stessa moglie Gostanza, si narra, che, per veleno da lei medesima propinatogli, morisse in Messina il 28 settembre 1197. Rimasta Gostanza assoluta Regina, inviava deputati al Pontefice, affinchè consentisse che il cadavere dell’Imperatore si sotterrasse in sacrato, e la investitura del Regno al suo figliuolo Federigo concedesse. Rispose Celestino, la sepoltura in sacrato ad Enrico non concederebbe, se prima non si ristorasse Riccardo Plantageneto del danaro estorto, allorchè ramingo pei suoi dominii lo aveva tanto vilmente imprigionato: la investitura a Federigo non ricuserebbe, dove pagasse mille marchi di argento ai Cardinali. Volendo Gostanza adempire la prima condizione, e riputando che sarebbe stato un fare ingiuria alla memoria del defunto marito restituire direttamente il danaro a Riccardo, come cosa rubata, si avvisò, che col dare all’Abbate Cistercense trecento marchi di argento, l’affare sarebbe composto; ma l’Abbate ricusò, dicendo, non potere offrire su l’altare di Cristo altre oblazioni che quelle monde di ogni nequizia umana. Finalmente si trovò modo di far seppellire Enrico dentro un’arca di porfido nel Duomo di Palermo, dove attualmente aspetta il giudizio di Dio. Per la seconda condizione tutto fu in breve accomodato, e Federigo ricevè la investitura del Regno. Così ridotte in buono stato le cose, moriva Gostanza il 25 novembre 1198 lasciando con poco retto consiglio Innocenzio III, creato Pontefice in quell›anno medesimo, tutore del figlio Federigo, e assegnandogli, perchè non ricusasse, l›annuale pensione di trentamila tarì.
Noi non istaremo a narrare come adoperasse Innocenzio la sua qualità di padre del pupillo Federigo, per togliergli gran parte dei feudi donati da Enrico VII ai suoi cavalieri, protestando esser parte delle donazioni di Carlomagno, e della Contessa Matelda: non come dopo una rotta di Marcovaldo tedesco, che pretendeva sottomettere la Sicilia, supponesse un testamento di Enrico VII, nel quale, tra le altre disposizioni, si ordinava al figlio Federigo riconoscesse il Reame della Chiesa, ed alla Chiesa, lui morto senza figli, ricadesse; non come, incapace a difendere il Regno dai Tedeschi, chiamasse con poca prudenza Gualtieri di Brienna, marito di Albinia, figlia di Tancredi liberata dalla prigione di Enrico, il quale avrebbe certamente spogliato del Regno il giovanetto Federigo, se per irrimediabile piaga, ricevuta in un fatto d’arme sotto Samo contro il Conte Diopoldo, non avesse perduto la vita; nè pure narreremo come Filippo, zio di Federigo, invece di sostenere le parti del nipote in Germania, se ne facesse incoronare Imperatore a Magonza, mentre un altro partito coronava Ottone, Duca di Aquitania, in Aquisgrana; non come Filippo, aiutato da Filippo Re di Francia, fugasse Ottone da Colonia, sovvenuto da Riccardo Re d›Inghilterra, e come indi a poco assassinato dal Signore di Witellaspach, al quale tradiva la promessa di dargli in moglie sua figlia, lasciasse Ottone pacifico possessore dell›Impero: solo racconteremo, che il Papa, di cui continuo disegno era impedire la riunione del Regno di Napoli agli Stati degl›Imperatori Germanici, consentì, in danno di Federigo, col trattato di Spira, coronare Ottone in Roma. Scendeva questi per la valle di Trento in Italia, assumeva la corona reale a Milano, la imperiale a Roma; ma giunto al sommo della sua dignità, scoprendosi avverso al Pontefice, negò cedere il patrimonio della Contessa Matelda, e si volse alla conquista della Sicilia. Innocenzio, non avendo armi, adoperò le scomuniche; e tanto erano tali mezzi potenti a quei tempi, che gli Arcivescovi di Magonza, di Treveri e Turingia, il Re di Boemia, il Duca di Baviera, con molti altri Baroni dell›Impero, di súbito ribellatisi, strinsero lega con Filippo Augusto contro Ottone, e riuniti a Bamberga lo dichiararono decaduto dall›Impero, e Federigo in suo luogo surrogarono. Ottone, abbandonato ogni disegno in Italia, torna velocissimo in Lamagna. Veramente Innocenzio non avrebbe voluto che Federigo si mescolasse nelle cose dell›Impero, ma adesso non gli si presentava persona migliore per opporla ad Ottone, e nelle cose di questo mondo bene spesso non si fa come si vuole, ma come si può: certo è poi che questo fu caso unico di vedere i Ghibellini prendere le parti della Chiesa, e muoverle contro i Guelfi.
Intanto Federigo lasciato Napoli si porta a Genova, poi ad Aquisgrana, dove Re dei Romani lo confermarono. In questa, Ottone muovendo contro Filippo Augusto di Francia pervenne al ponte di Bouvine, tra Lilla e Tournay, dove il 27 luglio 1214 toccò la memorabile rotta, per la quale disperando di più risorgere si ritirò al castello di Harburgo a piangere le sue colpe, e logorare tra le penitenze la vita. Innocenzio percosso da gravissima malattia si moriva: fu egli uomo di molta dottrina, delle cose legali intendentissimo profondo, cupido di regno. Il suo Pontificato va famoso pel fondamento che dette alla Inquisizione; imperciocchè sebbene il Tribunale del Santo Officio, propriamente detto, cominci sotto Innocenzio IV, pure fu Innocenzio III, che commise a San Domenico di Guzmano predicasse contro gli Albigesi, e con ogni sforzo s›ingegnasse a distruggerli.
Erano gli Albigesi una setta di Manichei fuggiti dall›Asia per le persecuzioni degl›Imperatori Greci, e ricovrati in Linguadoca presso il Conte Raimondo di Tolosa: si chiamarono anche con diversa denominazione Paterini, da Puti (soffrire), per distinguersi dai Martiri della Chiesa cattolica. Consisteva la eresia loro nel credere la esistenza di due principii, l’uno buono, l’altro tristo. Attribuivano al primo il Testamento Nuovo, al secondo il Vecchio: negavano la discesa corporale del Salvatore su la terra; credevano gli uomini angioli decaduti, che dovevano tornare un giorno alla gloria antica; rigettavano le indulgenze, il purgatorio, e i miracoli, non meno che la transustanzazione , il culto della Vergine, la dannazione dei fanciulli morti senza battesimo. San Domenico, per consiglio del Pontefice, recatosi nella Gallia Narbonese, suscitò contro essi una Crociata, concedendo quelle medesime indulgenze, che solevano darsi a coloro i quali passavano a combattere in Terra Santa.
Ora San Domenico, sovvenuto dal Conte Simone da Monforte, scorre i contadi di Tolosa, Albi, Carcassona ed incendia Beziers; finalmente, seguendo il suo cammino, cade in potere degli Albigesi, i quali gli domandano se tema la morte: «Io temere la morte!» rispondeva il Santo «io temere la morte per la fede, per la gloria di Cristo, e della Santa Chiesa romana? Non mi uccidete a un tratto, vi prego, ma a poco a poco mutilate ciascheduno dei miei membri, e mostrateli ai miei occhi; poi strappate anche questi, e lasciate così il mio corpo, in mille parti piagato, rotolarsi dentro il suo sangue, finchè giunga il punto della morte.» Gli Albigesi lo lasciarono in libertà.
Innocenzio non potè mai ottenere da Federigo, che decretasse la pena di morte contro questi, ed altri eretici, siccome Arnaldisti, Gazari etc. – Onorio III suo successore valse però ad ottenerla, come si rileva dalla costituzione Hac edictali conservata nel Codice Giustinianeo. A noi duole non potere più a lungo seguitare la storia degli Albigesi, chè il nostro soggetto ci preme; onde null’altro possiamo fare di meglio che rimandare il lettore all’opera che l’irlandese Mathurin con tanta forza d’immaginazione ha composto intorno le loro vicende.
Onorio III, conformandosi in tutto alla politica d’Innocenzio, esitava a concedere la corona Imperiale a Federigo; nondimeno costretto poneva per condizioni, che il Regno delle Sicilie al suo figliuolo Enrico cedesse, la Contea di Fondi alla Chiesa restituisse, egli a militare in Palestina trapassasse. Federigo prometteva tutto, perchè a promettere non iscapitava nulla; ma ricevuta la corona imperiale, se ne andò in Puglia: dove, vinti i Conti di Aquila, di Caserta, Tricarico, e Sanseverino, acquietò il Regno, vi promosse le arti e le lettere, instituì Università; e molte altre cose così per la pace, come per la guerra lodevoli, condusse a buon fine. Il Papa, che non voleva venire ad un’aperta rottura con Federigo, e d’altronde lo temeva vicino, si avvisò, per mandarlo in Palestina, di dargli in isposa Yole figlia di Giovanni di Brienna erede del Regno di Gerusalemme. Lo Imperatore, che poco tempo innanzi aveva perduta la prima moglie Gostanza di Arragona, tolse ben volentieri Yole, che fanciulla leggiadrissima era; ed apprestata una flotta s’incamminò col Langravio di Turingia alla conquista di Gerusalemme l’otto settembre 1227. – Qualunque però ne fosse la causa, di lì a pochi giorni vôlte le prue, tornasi in Calabria, prorogando la impresa all’anno venturo.
Era morto il prudente Onorio, ed in suo luogo sedeva Gregorio IX dei Conti di Signa, siccome Innocenzio III, il quale forte sdegnato del ritorno di Federigo, senza nè pure citarlo, lo scomunicò nel settembre di quell’anno medesimo 1227. Federigo per niente sbigottito appella da questa sentenza al Concilio, ordina continuarsi nei suoi Stati gli uffici divini, lascia al governo del Regno il suo suocero Giovanni di Brienna, e si reca a Tolemaide. Quinci mandava Legati al Papa, affinchè si placasse; questi rispose, instigando il Brienna a ribellargli il Regno. Federigo, fatta pace col Soldano, torna in Italia, vince il Brienna e il suo esercito, distinto col nome di chiavesignato da quello di Federigo, che si chiamava crocesignato. Il Papa è costretto a ricomunicarlo.
Le città lombarde erano già decadute da quelle virtù, che le avevano unite nella gloriosa Lega contro il Barbarossa. Cominciarono le contese cittadine tra nobili e popolo, aprendo così la via al primo ambizioso che volle dominarlo. Già fino d’ora molti cittadini reggevano la patria loro a modo tirannico, siccome i Signori da Romano, da Cammino, da Este, da Doara, e Pelavicino: in breve la stessa Milano vedremo cadere sotto il dominio dei Signori della Torre. Imprevidenti però del pericolo vicino, temevano il lontano, onde i deputati di Bologna, Piacenza, Milano, e di altre ragguardevoli città, si ragunarono nella chiesa di Santo Zenone di Mosio su quel di Mantova, e quivi stabilirono la seconda Lega Lombarda per quindici anni. Intanto Enrico, sollecitato, secondo che porge la fama, dal Papa, e dai Lombardi, si ribellava a suo padre. Come questa vicenda avesse fine vedemmo al Capitolo quinto. Ormai Federigo, non potendo più comportare il manifesto disprezzo che i Milanesi facevano della sua autorità, dichiarò loro la guerra. La minuta descrizione delle cose particolari di questa impresa vorrebbe altra estensione di quella propostami nel presente Capitolo: narrerò i fatti principali soltanto, e da prima la battaglia di Cortenuova, nella quale ebbero i Milanesi dolorosa sconfitta. Tornava nell’agosto 1237 Federigo di Lamagna, conducendo seco duemila cavalieri tedeschi: giunto che fu a Verona, occorse in diecimila Saraceni, ed aggiuntili al suo esercito entrò sul contado di Brescia. I Milanesi con la gente della Lega si posero subito in cammino, e andarono ad incontrarlo sull’Oglio. Bellissima era la situazione presa, per modo che Federigo, non volendo assaltarli con tanto suo manifesto svantaggio, s’ingegnò di trarneli fuori, valicando il fiume a Montecorvo, e spargendo la fama di andarsene a svernare a Cremona. Rimasero all’inganno gli avversarii, che stimando poterlo leggermente danneggiare per quella confusione che mena sempre seco la ritirata, si dettero ad inseguirlo. Pervenuti a Cortenuova, invece di fuggente, trovarono lo esercito imperiale schierato in ordine di battaglia: di tornare indietro non era più tempo; e’ fu mestieri combattere. Ma disordinati, siccome avviene a cui insegue troppo fidente della vittoria, e stanchi dal travaglioso cammino, furono abbattuti, e dispersi. Solo la compagnia della morte tenne fermo all’urto della cavalleria tedesca, e con valore inudito resse fino a notte, difendendo il Carroccio, nè si ritrasse prima di averlo spogliato di ogni suo ornamento. Più del giorno fu sanguinosa la notte, imperciocchè i fuggiaschi non potendo salvarsi pel contado cremasco rimontarono l’Oglio, e si dispersero per quello di Bergamo molti rifiniti dal disagio caddero morti per via; molti per quei sentieri paludosi, o tentando tragettare il fiume, si sommersero; moltissimi dai Bergamaschi sollevati contro di loro furono uccisi. Tra per la battaglia, tra per la fuga, meglio di cinquemila uomini perirono; sarebbero morti tutti, se Pagano della Torre Signore di Valsassina non gli avesse raccolti, e questo fu il principio dei Della Torre in Milano. Pietro Tiepolo, figlio del Doge di Venezia, Podestà, imprigionato da Federigo, è da lui indegnamente fatto decapitare in Puglia, su la torre di Trani posta lungo la riva del mare, affinchè la flotta veneziana, che per quelle spiaggie veleggiava, lo potesse vedere. Seguiva l’assedio di Brescia, nel quale si rinnuovarono tutte le barbarie adoperate dal Barbarossa nello assedio di Crema: ma Federigo non potè superarla, e gli convenne ritirarsi a Cremona senza avere nulla acquistato. I Veneziani, tutti sdegnosi della morte del Tiepolo, presero parte alla Lega; il Papa Gregorio non solo si univa contro Federigo, ma ben anche lo scomunicava. Allora non si conobbe più freno: intese l’Imperatore a sollevare gli Stati del Papa; il Papa, a sollevare quelli dell’Imperatore. Federigo però più potente in armi, meglio istruito nell’arte di lusingare le passioni, superati gli ostacoli, va a Roma. I Romani gli si dimostrano favorevoli, il Pontefice parve ormai disperato. Mentr’egli tutto dolente stava ad aspettare gli ultimi danni, gli sorge in mente un pensiero, donde nacque la sua salvezza: si volge al Vaticano, toglie le teste di San Pietro e di San Paolo; le porta in processione per tutta la città, rimettendo a quei Santi la cura di difenderla: se ne commossero i Romani; di nemici che gli erano, si convertirono subito in caldi difensori, e presa la croce, si dettero a combattere Federigo; il quale sebbene facesse tra crudelissimi tormenti morire quanti crocesignati gli capitavano in mano, pure non potè superare Roma, e sdegnoso e avvilito si ridusse nei suoi dominii di Puglia.

