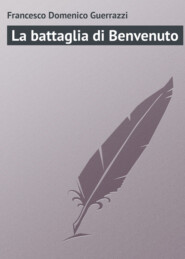
Полная версия:
La battaglia di Benvenuto
Ma sotto una volta del castello capuano, splendida dimora del Re Manfredi, che mena ai giardini reali, un giovane insensibile a tanta magnificenza della Natura traccia sopra la sabbia disordinati segni con la punta della spada. Bello e maestoso si presenta allo aspetto: i biondissimi capelli divisi in mezzo alla fronte gli pendono giù per le spalle; il volto per ogni parte leggiadro; ma i suoi grandi occhi azzurri spesso si avvolgono ferocemente sotto le ciglia abbassate, spesso si fissano immobili, e in diversa direzione, per la intensità del pensiero, come se osservassero alcuna cosa al di là di questo mondo. Sopra la sua fronte sta un segno che non vide mai la fronte della giovinezza. Qual cosa può avere impresso questo marchio inamabile degli anni su la testa di colui che ne vide trascorrere venti soltanto? L›amarezza dell›anima numera gli anni nel volto del travagliato, e quel segno sta sopra il suo capo come la corona del dolore.
Sciagurato! Non carezza materna acquietò mai il suo pianto; non bacio di padre lo rallegrò nei giorni della infanzia; egli non conobbe padre, nè madre. Sta nella vita come pianta nel deserto. – Ricerca la sua memoria, e trova in quella la solitudine dell›intelletto: solo lontano lontano alcune rimembranze di sangue… ma confuse, ma oscure per modo, che invano si sforza richiamarle più specialmente al pensiero. La sua anima arde quanto il sole sotto il quale egli nacque; la sua nascita lo affanna: un senso segreto di grandezza lo travaglia; anela una cosa che neppure egli conosce; vorrebbe con uno sguardo penetrare nei misteri della creazione, vorrebbe con un moto dominare i popoli della terra, vorrebbe essere un Dio con gli attributi dell›uomo, o un uomo con la scienza e la folgore di Dio. Ma l›alta fantasia, considerando il suo misero stato, sviene nello ardore della immagine; il suo cuore allora geme straziato dall›angoscia, sente tutto il tormento del delirio dell›ambizione. Forse questo fuoco avrebbe da gran tempo consumato la sorgente della vita, dove una forma di celesti sembianze non gli sorgesse nell›anima, e ne acquietasse alcuna volta le tempeste. Certo, quello è un amore disperato; e ben degno di lui. Il solo pensiero, se gli uomini potessero conoscere il pensiero, sarebbe punito. Uno scudiero osa sollevare lo sguardo alla figlia de› Re? Quali sono le sue speranze? Confida che la vergine del sangue svevo piegherà il cuore fino a lui? Conosce i pericoli, pensa ai tormenti che sono per occorrergli? Egli ama, e disperatamente ama.
Ma i suoi sguardi da lungo tempo insensibili a quanto di più solenne gli profferiva la Natura, si affissano a un tratto su la magione del figlio di Federigo. Il castello capuano sembrava veramente dimora da Re: ma se per la mole appariva quale la creatura memore esser parte del Creatore può immaginare, per la sua fortezza era pur quale il tiranno nell›agonia della paura può eleggere: conciossiachè Guglielmo il Tristo della stirpe normanna a difesa della propria vita lo fabbricasse. Mura grossissime. frequenti torrioni, cavalieri, baloardi, e tutti gli accorgimenti che l’arte nel dodicesimo secolo consigliava, erano stati adoperati per sicurare il tiranno tremante: ma invano! – dove la vendetta degli uomini manchi, veglia il giudizio di Dio: egli moriva, e non di ferro: ma la sua stirpe fu spenta; il trono fondato dal valore di Roberto Guiscardo, e dal Conte Ruggiero, cadde sotto la eterna giustizia, che i delitti di Guglielmo I fece scontare allo sventurato Guglielmo figlio di Tancredi Conte di Lecce.
Federigo II volle rendere più lieto il castello, allorchè, condusse, a Napoli Niccola Pisano, il più grande artefice del suo secolo, e gli commise la cura di adornarlo. Ma il genio dell’architetto piegò suo malgrado alla vista dello edifizio che migliorava, e i suoi trovati non fecero che aumentarne l’orrore. – Così l’armonico Trovatore se nel silenzio della notte si avvisa cantare la canzone giocosa, gli sfuggono suo malgrado mestissime note, e finisce con la ballata del dolore.
La luna, che tutta lieta di trascorrere i cieli, non cura se in terra sia maladetto o benedetto il suo raggio, e lo diffonde sul volto dell’amante che accelera col desio l’ora del colloquio di amore, e sul volto del sicario che si slancia dalla tenebra, stende il colpo, e ritorna nella tenebra, manda la sua luce sul castello capuano. Le parti illuminate di questo edifizio sembrano anche più grandi pel contrasto delle ombre in cui le altre parti sono sepolte. Alcuni torrioni paiono non aver fondamento sulla terra, e starsi così sospesi per l’aria; altri mezzo rovinati; e presentano alla fantasia uno di quei castelli che i romanzieri descrivono nelle loro leggende: dove gli spiriti maligni si ragunano a celebrare il nefando sabbato e a inebbriarsi di sangue. La calda immaginazione dell’osservatore può vedere avvolgersi per quelle rovine lo
spettro di Guglielmo il Malvagio condannato a visitare la casa da lui eretta, abitata da stirpe non sua; e può sentire il singulto dell’ira, o della coscienza, ch’ei manda nella disperazione dell’anima.
Tale era lo edifizio che il giovane considerava. Poichè l’ebbe con lentissimi sguardi e più volte misurato, scosse la testa, e parlò: «L’opera della tirannide è grande quanto l’opera della generosità… La paura ha dato il suo sublime, come lo ha dato la pompa… il buono e il tristo produssero parimente le maraviglie del volgo, che sono la compassione della debolezza umana per coloro che han cuore. – Santa Maria! Che cosa egli è mai questo castello? Che i tesori che trovò Manfredi in Luceria? Che la potenza di Federigo Barbarossa, e di Federigo II? Essi non poterono conquistare la Italia: quegli fu arrestato da mura di creta e di paglia; questi disfatto da gente, dalla quale si allontanava per non vedere la morte. E poi che sarebbe l’impero d’Italia, quello del mondo? Potresti essere il più grande di tutti i mortali, ma pur sempre mortale; il più forte tra gli uomini: – ma chi vanta nel braccio la forza del turbine? Il più sapiente dei figli della terra: – ma chi ha lo intelleto dei figli del cielo? Pure l’anima mia potrebbe questo sentimento che mi travaglia la vita obliare o almeno lenire, dove potessi posare la testa sul seno… di cui? Non l’ho io nominata? Non sono i passi di uomo questi che si allontanano? – No… tutto è tranquillo. Fino tremare di nominarla! O capuano! io sarei contento delle tue mura; o soglio del mio Re, comunque angusto, mi giungeresti ben grato, dove io mi vi potessi sedere con quella che ho fatto donna dei miei pensieri? Io ho amato sempre il trono perchè mi sento nato per quello: ora poi questo desiderio è diventato furore, perchè in altro modo che sul trono non si può vivere con lei… nè, se si potesse, il vorrei… Ma io sono un oscuro… nudrito per pietà in casa non mia, costretto a servire con mente da dominare… non conosco padre nè madre… e devo tremare di conoscerli, perchè forse il mio nascimento va macchiato con nota d’infamia.»
E qui tacque: un pallore mortale gli si diffuse pel volto: stette immobile con intentissimi sguardi, e con la bocca mezza aperta, come il tormentato dalla sete; giù per le guancie gli trascorrevano grosse stille di sudore che gli scaturivano frequenti dalla fronte, quasi spremute dal cervello compresso dall’angustia. Dopo alcun poco il sangue tornò impetuoso per modo a infiammargli la faccia, che le vene inturgidite e i muscoli dilatati pareano doversi spezzare alla violenza del moto: allora tutto il suo corpo si agitò convulso, e si pose ambe le mani sul capo quasi per impedire che si rompesse. Stato tanto miserabile non poteva prolungarsi più oltre, ed egli cadde gemendo sopra un sedile di pietra.
«Oh questo non può durare,» dopo lunga ora riprendeva in fievole accento «non può durare, nè durerà. – Poichè la morte è certa, proviamo morire con ardimento, e sveliamoci. – Con ardimento! Ma questo potrebbe fruttare l’onta del rifiuto; e mentre stimava morire da generoso, sarò sprezzato dall’orgoglio, e forse vilipeso come stolto. Santa Maria! Che vita è questa dove la pratica di una virtù partorisce il frutto del delitto, e la pratica del delitto la mercede della virtù? Chi è il sapiente che ne ammaestra a distinguere l’uno dall’altra? Chi quegli che ne insegna in che cosa consistano? Il delitto di questo secolo stimarono e stimeranno il delitto dei secoli futuri? Virtù che mi nuoce è sempre virtù? Devo praticarla a mio danno? Dove ha scritto la natura le sue leggi? – Nel cuore? Io sovrappongo la mano al cuore, ma egli palpita al sussulto delle passioni. – Che serve meditare su la ragione della necessità? Meglio vale subirla con le mani incrociate sul petto, e starci a vedere che cosa ne viene. Così farò.
– Dunque sono io tanto sventurato? La mia memoria non può ricordare nulla che giovi a blandire con le illusioni un’anima lacerata da tante angoscie reali?– Oh! bello lusinga il regno delle immagini, ma il loro fascino è come quello del serpente; questo finì col peccato, quelle finiscono coll’inaridire la mente che a loro si abbandona. – Pure il giorno che il suo genitore assunse la corona de’ Re, ella lasciava cadere ai miei piedi la grimpa che le cingeva la persona: io la raccolsi… e meco trionfò nel torneo… ed ora mi posa sul cuore, e sarà la compagna della mia vita, e mi coprirà la faccia nella fossa.– E il giorno del torneo? O sola luce dei miei anni passati! Oscuro donzello, ricoperto di maglia, coi colori della figlia di Manfredi, mi confusi tra i superbi Baroni e capitani famosi, ed osai giovinetto giostrare di lancia co’ maestri dell’arte, con cavalieri incliti per mille prove, e vinsi. Rimaneva il prode Conte Giordano di Angalone: ci affrontammo; ei cadde rovesciato sopra la polvere. Egli ne dette la colpa alla cinghia della sella, e sarà, ma cadde. – Io mi nascosi, egli ebbe il premio della giostra, dacchè il vero vincitore non si presentava; nè io lo invidiai, chè mi parea avere più alto premio conseguito che il suo non era, – l’amore della figlia del Re. – E il giorno veniente? Oh! non dimenticherò mai il giorno dodicesimo di agosto. Io le guidai il bianco palafreno: – ella in salendo pose la sua nella mia mano… e tremò… ed io pure tremai, ed arrossii. – Ma ed ella arrossì? Io non osai sollevare gli sguardi. Oh! quella fu gioia, e… forse fallace. Chi sa che il velo non cadesse per caso? Chi mi assicura che il suo tremore non venisse da pericolo di caduta? o piuttosto da sdegno del mio tanto ardimento? Il sangue svevo ribolle superbo: ma se orgoglio facesse lignaggio, io pure mi sentirei sangue di Federigo. – E quando ella inchinandosi dalla sua altezza m’interrogasse: chi sei? – Chi sono? – Uno ignoto a me stesso, e ad altrui; un respinto per la colpa materna dal seno dello stesso genitore, un monumento vivente del peccato, una onta a me, una vergogna ai miei. O chiunque voi siate che mi donaste una vita che non avrei accettata giammai, dove si potesse rifiutare di nascere, grandi devono essere stati i vostri peccati, perchè atroce è la pena che ne porto!»
Così parlava il travagliato, alternando la vicenda del dolore e della gioia, allorchè la natura lo sovvenne con la stanchezza, e il bisogno del riposo lo costrinse a sedersi. Le sue labbra presero ad articolare le note di una mesta ballata, e la mente seguace dell’armonia si deliziò nei concenti divini, nati e custoditi sotto il cielo d’Italia. – All’anima confortata si affacciò quindi il suono delle imprese guerresche: egli lo cominciava leggero leggero: a mano a mano cresceva; finalmente si sollevò al punto, in che si ode quando il nemico si riversa sull’inimico. Allora trascorse nei giorni della gloria, sentì l’alito della fama, sorse, tolse la spada, e nobilmente avvolto nel mantello camminò nell’orgoglio della mente sollevata fino al pensiero dell’Onnipotente Distruggitore.
CAPITOLO SECONDO. AMORE
Pargoletta ella era
Tutta sorriso, tutta gioia: ai fiori
Parea in mezzo volar nel più felice
Sentiero della vita. – Ecco ad un tratto
Di tanta gioia estinto il raggio, estinto
Al primo assalto del dolor.
Francesca Da Rimini, tragedia.Perchè una tomba prodigio di marmi peregrini e dell’arte copre le ceneri di tale, che non si conosce essere stato vivo, tranne pel monumento della sua morte?– Perchè forme celesti, dilicati contorni, leggerezza di leggiadrissimo corpo, vestono l’anima della femmina? Perchè ci dierono un cuore che balza a quelle sembianze, una fibra che si raccapriccia a questo bellissimo spettacolo della creazione? Nessuno animale ha potuto contribuire a formare il corpo della femmina. I colori dell’uccello di paradiso, della farfalla di Casimira, non possono paragonarsi ai divini che imporporano le guancie della bellezza. La gazzella non ha l’occhio della donna: le pietre preziose non brillano di quella luce; e i poeti, per assomigliarli a qualche cosa di convenevole, hanno dovuto ricorrere al firmamento. Ma nessun rettile, quantunque schifoso, fu eccettuato dal somministrare parte nella composizione dell’anima che agita i moti delle sue membra; nessuno, meno lo scorpione, che circondato dal fuoco volge in sè stesso il dardo velenoso, e generosamente si uccide. Tu sei bella, o creatura, ma la tua bellezza porta una impronta tenebrosa; tu nasci figlia di un sublime pensiero, ma come Lucifero decadesti; i tuoi raggi come quelli del sole che tramonta feriscono, non consolano la vista; la tua bellezza è il nostro tormento. Ma andiamo affannosi in traccia di quella innocenza che Eva lasciava nell’Eden, e questo è il più fiero travaglio del cuor nostro. Ma il tuo cuore ugualmente fu condannato a spezzarsi per la nostra incostanza. Forse tu dovresti essere maladetta, perchè la prima a peccare; ma il serpente abita nelle tue fibre dilicate: la curiosità genera la sapienza, in te partoriva la colpa. – Tu schiudesti la via dei delitti, noi vi ti abbiamo superato… Oh, figli della polvere, non vi maladite, ma abbiate misericordia tra voi!
Nelle sale del castello capuano vive una creatura divina nelle forme, divina nell’anima. Ella teneva la faccia adagiata sopra un origliere, e gli sguardi dimessi: una bellezza maestosa compariva per tutto il suo aspetto. Molte damigelle le stavano attorno, e tacite tacite facevano voto che sollevasse gli sguardi, i quali, sollevati, non potevano sostenere; perchè siffatta luce ne usciva, che svelava un’anima, la quale non si sarebbe mai creduto avessero potuto reggere quelle sue membra dilicate. Ella era leggiadra quanto la madre degli uomini, che il divino Ghiberti effigiava sorgente dalla carne di Adamo, e sorretta dagli Angioli a riporre in pegno di amore la sua mano nella mano di Dio. Certo ella non pareva figlia di nozze mortali: forse i connubii dei figli di Dio, allorchè sentirono amore per le belle figlio di Caino, l’avrebbero potuta generare, ma lo spirito dell’Eterno non benedisse quei maritaggi, perchè esse nacquero nel peccato, onde ne vennero i Giganti e Nembrod il feroce cacciatore al cospetto di Dio.
Invano cercheremmo voci nelle favelle della terra che valessero a ritrarre quella immagine di beltà: e sarebbe più facile suscitare la luce dalle tenebre, e dare anima ai figli d’Italia.....
Dopo lungo tempo si levò dal suo seggio, e si fece verso il balcone: era il suo passo leggero, come vento che folleggi tra le rose, o come incenso che s’innalzi alla Divinità: l’onda delle vesti ventilando spargeva odorosa fragranza: non mesta, nè lieta; ma nella calma solenne della considerazione, allorchè il lampo del pensiero balena su gli avvenimenti dei secoli, allorchè l’orecchio del divino intelletto intende l’arcana armonia del creato, e il suo occhio finge nel cielo i figli della sublime immaginazione.
Fattasi al balcone, soprastette a considerare il firmamento, e sospirò; quindi rivolta alla damigella che le stava al fianco fece suonare una voce, quale certamente si diffonde quella di Eloa, l’angiolo che canta lo inno dei cieli innanzi al trono di Jehova.
«Vedi, Gismonda, come esulta il firmamento! Anche quando la religione non ce lo avesse insegnato, la mente nostra lo terrebbe per la dimora di Dio. – Oh! piacesse a lui chiamarmi presto alla sua pace!»
«Nobile Yole, il Signore è sapiente in ogni opera sua; egli solo conosce il bene e il male; noi dobbiamo aspettare adorando i decreti della sua giustizia.»
«Guardimi il cielo dal mormorare contro il mio Creatore, ma i voti dell’afflitta non possono giungere disgrati innanzi al suo trono.»
«Mia dolce donna, sta a voi innalzare a Dio i voti degli afflitti? A voi figlia del Re Manfredi, sorella della Regina di Arragona, nepote dei Federighi? A voi sangue della casa di Svevia, posta dalla fortuna nel più alto grado che mente mortale possa desiderare? La vostra vita si sprolunga innanzi a voi come sentiero di fiori; i vostri giorni numera il piacere: voi desio di ogni prode cavaliere; voi sospiro di ogni Trovatore, voi amore di tutti, non avete a temere le sciagure che travagliano la più parte della schiatta di Adamo.»
«Pure io sono tale che ormai più nulla mi resta a temere fuorchè l’ira di Dio.»
«E l’ira sua non verrà; ch’ei tempra i rigori del freddo all’agnello tosato, e versa il balsamo su le piaghe del doloroso.»
«Gismonda, la nostra casa venne respinta dalla comunione dei fedeli fin dal Concilio di Lione, dove, malgrado la difesa di Taddeo da Suessa, Innocenzo scomunicò Federigo. Certo, noi non patiamo difetto degli ufficii della Chiesa, ma Papa Clemente ha tolto appunto motivo da questo per confermare l’anatema contro di noi. Egli ha sciolto i vassalli dal sacramento di fedeltà, e senza questo già troppi ne circondavano traditori: egli cerca pel mondo un nemico del sangue nostro, e senza questo erano assai coloro che anelano un trono. La fortuna non ha concesso che Riccardo di Cornovaglia accettasse la nostra corona offertagli da tale che non sa acquistarla per sè e la dona altrui; nè che Edmondo d’Inghilterra abbia potuto muovere le armi contro di noi; ma al nemico vigilante di rado il tempo non porge la occasione, e Clemente è tale uomo da non lasciarla fuggire.»
«Figlia di Manfredi, il nemico non ha mai vedute le spalle del vostro genitore: se non avremo la pace, avremo la vittoria.»
«Amen, Gismonda, amen. Ma vedi quella cometa lassù nell’orizzonte, che sorgendo da oriente percorre il cielo verso occidente, e si ferma sopra di noi? Hai tu inteso quello che ne dicono gli astrologhi? Ella è certo segno di morte di Re, e di tramutamento d’Imperii. Io stimo non vivere persona al mondo che sappia sostenere la sciagura senza gemere, quanto la figlia di Manfredi: – ma la sciagura, comunque tu la sopporti, è pur sempre sciagura.»
«Nè io vo’ porre in dubbio la influenza delle stelle: ma per gli effetti comparsi fino ad ora sopra la terra, parmi che ne possiate andare piuttosto lieta che mesta. La cometa apparve di agosto, e Urbano IV moriva di novembre.»
«Ma la cometa non per anche scomparve. Credilo, Gismonda; un gran Re deve morire, e Carlo d’Angiò è Conte di Provenza soltanto.»
«Ed egli sarà Re prima di entrare nel Regno. La sua strada non dove essere per Roma? Quivi riceverà certamente la corona, e la benedizione; e possa questa giovare alla sua anima, come quella non fregerà mai la sua fronte.»
«Oh! – se i Baroni del Regno fossero fedeli come sono potenti, la corona di Manfredi non circonderebbe mai le tempie di Carlo: – ma qui i traditori vivono infiniti, e più che di altrove sembrano pianta naturale a questa terra, e a questo cielo. Molti i nemici di mio padre, che egli nel percorrere la via del trono vinse, e perdonò: ma il perdono non sana la piaga dell’orgoglio ferito, nè toglie l’odio, perocchè non v’abbia cosa al mondo che tanto avvilisca quanto il perdono del nemico; e questi al primo grido di ribellione vedrai riparare allo stendardo dei gigli, e combattere con quel furore che solo possono dare i rimorsi del tradimento. Pure non questi soli si scuopriranno nemici: vi sono uomini pei quali l’altrui felicità è una spina: sempre tristi per la invidia che li tribola, guai se osi manifestare il sorriso della tua gioia innanzi il cospetto loro! essi ti notano, t’inseguono, nè ti lasciano mai, finchè con molti anni di ambascia tu non abbia scontata la gioia di un momento. – Il pianto è la loro armonia, l’urlo della disperazione il diletto; e il cuor loro non sussulta tranne alla vista delle rovine. E gli amici?… Essi son molti nel tempo felice: nè in ciò io accuso gli uomini, no; la natura ha posto nel nostro cuore una voce che grida: sii felice solo: nè io già gli maledico come spietati; poichè sia bello salvare l’amico, ma dove non tel concedano i casi tu non devi amare l’amico più di quello che ami te stesso. E tu, mia diletta Gismonda, che meco fosti nutrita e cresciuta, e che un vincolo di scambievole amore unisce meco in fraterna corrispondenza, tu stessa a cui adesso sembrano nulla il disagio, il vituperio, e la morte, rispetto al dovermi abbandonare per sempre, tu pure un giorno mi dimenticherai.»
Gismonda vinta dal dolore non rispose; chinò la testa, e grosse lacrime le ricorsero agli occhi: gli socchiuse l’affettuosa per nasconderle alla vista di Yole. ma la passione nol sofferse: tornò a sollevarli verso la sua donna; e non vedendola commossa, la piena del cuore gittato ogni freno proruppe. Un singhiozzare frequente dimostrava quanto grande fosse stata la offesa per la gentil damigella.
Yole la sogguardò, e soggiunse: «Ella è così… l’uomo s’offende al detto di quello che deve praticare col fatto. Un senso arcano e generoso, cui non sappiamo da qual parte ci venga, ne ammaestra che partecipare lo infortunio con l’amico è bene, ma la natura nol consente, chè non ne ha conformati in guisa, che il nostro più fiero nemico sia il patimento, e più possano in noi gli strazii dell’angoscia, che non le lusinghe dell’amore… Ella è così; nè io voglio accusartene, o mia dolce Gismonda; il fallo proviene da più alta cosa che non sei tu. Chi è che osi contrastare al grido della natura? Noi non siamo da tanto, nè io vorrei da te più di quello che puoi darmi. Gismonda, mia cara Gismonda! se alcuna cosa ti ho mai fatto di grato; se la mia memoria sarà tale che possa dilettare la tua mente, io ti prego, che quando in questo stesso castello la voce del nuovo signore ti chiamerà a stare appresso alla sua consorte, od alla figlia (poichè tu sei il più nobil sangue del Regno), se mai avvenga che acciecate dalla vittoria rigettino le preghiere degl’infelici, e dall’altezza in che le pose la fortuna schivino chinarsi al gemito che si solleva dalla polvere, rammenti a costoro ch’esse pure sono di polvere. – mutabile cosa essere la fortuna: – e poi soggiungi: era il sangue di Svevia quanto quello di Francia famoso: era la figlia di Manfredi anch’essa illustre, e pure il Trovatore e il Menestrello non avevano canzoni che tanto la dilettassero, quanto le parole interrotte e le lagrime dell’infelice confortato. E se il mio nome varrà a vincere l’orgoglio dei cuori, e dalla via della superbia dirizzare le avventurose sul sentiero del paradiso, sarà questo il gaudio più profondo che giunga all’anima mia, dovunque piaccia al mio Creatore collocarla. E dove mai la nobile consorte o la figlia del Conte avessero cuore che palpita alle miserie dell’umanità, e sorridessero del mio sorriso, allora amale, Gismonda, amale come mi amasti: non turbarle giammai col racconto delle mie triste vicende, nè col mio nome sminuire una gioia che il Signore non mi ha voluto concedere, e che a loro, siccome più meritevoli, ha compartita. Ma quando lontana da tutti, ridotta nella tua segreta cameretta, potrai liberamente trattenerti nella memoria degli anni che furono, oh! allora, mia cara Gismonda, allora donami un sospiro… un pensiero… una lagrima… Certo io conoscerò quella lagrima, e con una lagrima ti risponderò.»
Qui si rimase la bella addolorata: e mestamente volgendo gli sguardi, vide tutte le suo damigelle confuse di vergogna, e la gentile Gismonda in tale stato da non potere più intendere tanto disperate parole. Tacque: un lungo silenzio si sparse per la sala: i doppieri mandarono una pallida luce su quelle donzelle atteggiate in sembianza di pianto. – Pareano statue d’illustre artefice destinate ad ornare le tombe dei potenti.
Yole, poichè lungamente stette pensosa, si scosse a un tratto, corse, si recò in braccio Gismonda, e con amore materno la confortava, o col suo proprio lino le sue lagrime asciugava: quindi con piacevole voce riprese:
«Oh! non piangere, Gismonda, non piangere. Malaugurata colei che sforza al pianto la faccia della bellezza! – Santa Vergine! la mia miseria soverchia l’anima mia, e mi conviene trasfonderla in altrui. – Madre degli afflitti! già troppe mi trafiggono amarezze, – bastino. Io sono innocente; ma s’è destinato ch’io beva il calice delle pene, non consumi meco i giorni della sua gioventù questa cara donzella. – Sia la mia causa separata dalla sua: io sola soffrirò per lei, pei miei parenti, per tutti.»



