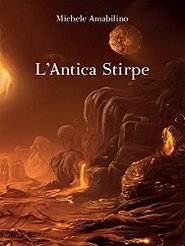скачать книгу бесплатно
L'Antica Stirpe
Michele Amabilino
E' un romanzo di fantascienza che riprende le teorie di Einstein e di Crick, un libro scritto con rigore scientifico, di avventura di dramma umano. Un romanzo a cinque stelle con recensioni e valutazioni.
Dario è un vecchio ospite in una struttura psichiatrica in una località del Piemonte. Intervistato da un giornalista scientifico che scrive su UFO e Extraterrestri, racconta una strana storia. Durante il secondo conflitto mondiale quando era giovane è stato rapito con due suoi amici e portato in un mondo lontano. Lo scopo : inseminare un pianeta giovane. Dopo molte avventure, aver conosciuto degli androidi costruiti dall'antica razza aliena aver visitato un pianeta morente ritorna con i suoi amici sulla Terra.
Indice
Cover (#ufbb64041-9aeb-5bd6-82bf-23ccdb7b5728)
Indice (#u9d1099af-72a7-5635-85a2-a65a3b8502b3)
Frontespizio (#u081d7dd2-c55c-5b4e-8d53-a1146ab73da4)
Copyright (#uf6699788-ca2c-5861-8e1e-83913101f412)
Capitolo (#u9af3c00a-20fd-566b-89d8-f72325c45318)
Michele Amabilino
L’Antica Stirpe
A Francis Crick
Titolo | L'antica stirpe
Autore | Michele Amabilino
ISBN | 9788873043225
Prima edizione digitale: 2014
© Tutti i diritti riservati all’Autore
Seconda edizione digitale: 2017
Tektime
traduzionelibri@tektime.it (mailto:traduzionelibri@tektime.it)www.traduzionelibri.it (http://www.traduzionelibri.it)
Questo eBook non potrà formare oggetto di scambio, commercio, prestito e rivendita e non potrà essere in alcun modo diffuso senza il previo consenso scritto dell’autore.
Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata costituisce violazione dei diritti dell’editore e dell’autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla legge 633/1941.
Giugno 1998, in una località del Piemonte...
Era una stradina stretta e asfaltata, che serpeggiava tra prati coltivati a mais e a grano. C’erano file di alberi frangivento e a perdita d’occhio, in lontananza, una catena montuosa di color azzurro con qua e là puntini bianchi di case e villette. Il traffico sulla stradina era scarso, attraversata di rado da qualche macchina, trattori e biciclette. Si poteva notare qualche maratoneta o ciclista per hobby.
C’era un’auto di grossa cilindrata, di color avorio che procedeva a media andatura. Una mercedes, il cui proprietario era un uomo di mezz’età dai modi colti. La macchina si dirigeva verso una costruzione, in lontananza, insolita per il suo stile, che non somigliava affatto a una azienda agricola o a una abitazione privata. Vista da vicino sembrava più strana perché aveva finestre blindate e servizio di sorveglianza a un cancello.
L’uomo che era alla guida dell’auto, molto distinto e di età matura, si qualificò alla sorveglianza come un giornalista e disse di essere atteso per un’intervista. Riconosciuto, gli fu aperto il cancello automatico, così l’auto sostò all'interno di un ampio parcheggio riservato al personale e ai visitatori. All’interno trovò una seconda costruzione, piuttosto bassa, di colore bianco, anche questa con finestre blindate.
C’erano stradine asfaltate, aiuole, siepi, alberi. Il tutto ben curato. Qua e là segnaletiche ai reparti e un grande quadro generale dei vari interni e dell’intero equipe medico.
Dunque era una clinica, piuttosto decentrata rispetto alle altre di città, e che mostrava una struttura moderna, funzionale e piuttosto... austera. Era chiaro che il giornalista si trovasse in una clinica per motivi professionali in quanto egli scriveva per una rivista, famosa e internazionale, specializzata in temi scientifici.
L’uomo scese dall’auto, si tolse gli occhiali da sole e prese sotto braccio una borsa da lavoro. Diede una rapida occhiata in giro e poi si diresse spedito verso una direzione. Era evidente che era stato già in quel posto e lo si capiva per il suo modo di fare sicuro. Giunto davanti una porta a vetri l’aprì ed entrò in una ampia sala.
L’ambiente era modernamente arredato con gusto signorile ma ugualmente freddo come lo sono in genere le cliniche o gli uffici commerciali.
Si rivolse cortesemente alla portineria interna e disse laconico: «Sono Tito Arnaldi, giornalista, per il solito colloquio...»
Il portiere visionò distrattamente il tesserino, annuì e gli indicò una porta poco lontana. Aggiunse: «La stanno aspettando» dopodiché fece un numero interno per comunicare con qualcuno.
Raggiunta una stanza che sembrava un piccolo salotto, il giornalista si sedette su di una poltroncina e prese da un tavolo con il piano di vetro, poco vicino, una rivista. La sfogliò distrattamente. Ed ecco in quell’istante giunse un giovane con pizzetto e baffi, di media statura, con un camice bianco e una targhetta con i suoi dati inserita e ben in evidenza.
I due si salutarono cordialmente come vecchie conoscenze.
Il medico: «Il paziente ha avuto un’altra crisi, è stato sedato e si trova ancora nella sua stanza imbottita ma lo farò uscire e darò disposizioni perché venga accompagnato in questo salotto per il solito colloquio. Attenda prego.» Detto questo si allontanò.
Dopo un’attesa di qualche minuto nella sala dei colloqui giunse un infermiere e un ricoverato.
Quest’ultimo era un vecchio mal ridotto, magro e dall’andatura stanca. Appena vide il giornalista si illuminò in volto, contento di vedere qualcuno che provenisse da fuori, dalla società. Il malato e il giornalista si sedettero di fronte, vicino a un tavolino, l’infermiere si allontanò un po’ ma rimase nella stanza, guardingo.
Si sentì la voce del sorvegliante dell’istituto con un tono poco professionale: «Mezz’ora, non di più, o si stanca troppo e magari dà i numeri...»
Il vecchio fece una smorfia di disgusto, di chi contesta tutto, anche la sorveglianza dei “matti” perché lui non si sentiva un matto ma una vittima della malasanità.
«Ci osservano, ci spiano» bisbigliò il vecchio al giornalista con un tono di complicità. «Vedi, ci sono telecamere dappertutto.»
Infatti quel posto era così sorvegliato da far invidia a una banca o a una galleria di quadri d’autore. C’erano elementi pericolosi, reclusi, individui cui la scienza medica si era arresa definendoli irrecuperabili. In quel posto isolato dal mondo, apparentemente lustro e confortevole, sopravvivevano persone che il mondo rifiutava da un pezzo, di cui sembrava vergognarsi. Era una prigione? Una casa di cura oppure un obitorio per viventi? Forse tutte quante le cose. Ma che cosa aveva fatto di tanto patologico quel vecchio che a stento si reggeva in piedi, chissà da quanti anni sepolto vivo in quella struttura?
Nessun crimine, forse qualche episodio di alienazione comportamentale, forse qualche comportamento strano, eccentrico, forse un modo di vivere e di vedere le cose del mondo in rotta di collisione con la comune ragione.
«Dario, permetti che ti dia del tu, tanto siamo amici ormai» così gli si rivolse il giornalista, con voce paziente. «Sono venuto a trovarti ancora, perché mi interessa la tua storia, tornerò ancora, e ti porterò altra cioccolata che ti piace tanto...»
Il vecchio gli rispose con fare nervoso:
«Sì, sì, torna ancora e portami altri blocchi di carta e delle matite. Sai, io disegno spesso. Mi piace tanto...»
«D’accordo, d’accordo ed ora raccontami della tua esperienza. Il tuo incontro del IV tipo.»
«Ah, è così che si chiama? Ma guarda che strano... La mia avventura è accaduta tanto tempo fa, quando ero ancora giovane. L’ho raccontata tante volte a tanti medici ma loro non mi credono, dicono che sono sogni, allucinazioni. Ma come è possibile? A proposito... l’altro giorno guardandomi su di un vetro ho visto la mia immagine riflessa, non è che mi guardo spesso perché di specchi non ce ne sono, dicono per motivi di sicurezza, ebbene ho visto un vecchio. Sono diventato vecchio, non mi riconosco più, non ricordo quanti anni ho e in che anno siamo. Ho girato così tante case di cura» sospirando.
Il giornalista lo fissò con occhio critico, studiando quei lineamenti marcati, guardandogli dentro gli occhi come per cercare un briciolo di lucidità che i medici sostenevano da tempo smarrita; nonostante tutto, si convinse di dare credito a quel matto, perché così era stato definito da quella struttura e da tante altre, per tanti anni e senza speranza.
Il vecchio con voce stanca continuò:
«Allora... mi ascolti bene. Questa storia l’ho ripetuta tante volte ed è la mia maledizione. Mi ricordo... ah come mi ricordo di quel mese di dicembre del 1942... io, Dario Filiberti, studiavo come perito agricolo e lavoravo per una masseria nei pressi di Castellamonte in provincia di Torino. Avevo degli amici, tanti, ma tra i più cari due di nome Mario e Gilda. Spesso andavo a fare baldoria con questo o con quello dopo il lavoro. Ricordo Mario e Gilda, ancora giovani, innamorati l’uno dell’altra. Ricordo Gilda, ragazza, solare e prosperosa... Noi tre eravamo spesso insieme, a ballare nelle feste di paese, ad alzare il gomito in quei maledetti giorni di guerra e di paura... Sembrava quella sera uguale a tante altre, fatta eccezione per una piccola bravata inedita. Avevamo preso in prestito la Balilla del padrone della masseria che si chiamava Piero e che era un vecchio rincitrullito dall’alcool. Lui se ne stava sempre in osteria a ubriacarsi, a cantare in coro vecchi motivi paesani o a giocare a carte con i beoni come lui. Così quella sera, io e i miei compagni, “rubammo” il suo macinino.
Avevamo deciso di fare una tirata, una bella corsa e poi una bevuta per dimenticare tutte le brutture della guerra, le bombe, i rastrellamenti e tutto un mondo che era diventato così precario, ma così precario da non lasciare più respiro né speranza per il futuro. Si diceva che la guerra sarebbe durata ancora a lungo e la propaganda fascista incantava i gonzi sulla magnificenza del prode esercito fascista, sulle vittorie della Germania, e il felice esito della guerra. Erano brutti tempi quelli, ma ancora più brutti per noi sfortunati ragazzi gettati a capofitto dentro un incubo.
Io ero alla guida della macchina in una stradicciola di campagna stretta e polverosa. I fari illuminavano la strada, la divoravano sollevando qua e là nuvole di polvere, noi guardavamo il paesaggio che era immerso in un buio pesto, puntellato da qualche fioca luce lontana di qualche casa. C’era un silenzio irreale e per qualche istante si poteva percepire la sensazione di' trovarsi smarriti, senza alcun punto di riferimento. Già, perché quella sera ricordo che c’era calma piatta, senza bombardamenti, senza il via vai dei mezzi dell’esercito o dei cittadini, tanto da dare l’impressione di non vivere la guerra in prima persona. C’era troppo silenzio, noi lo avvertivamo con una sensazione strana, di inquietudine. I miei due amici fumavano qualche cicca riciclata, si abbracciavano, guardavano fuori, in strada distrattamente, io li osservavo di tanto in tanto dallo specchietto retrovisore meravigliandomi del loro strano modo di comportarsi perché di solito manifestavano gioiosamente la loro voglia di vivere, vociando e ridendo.
Di tanto in tanto tentavo anche di rompere il silenzio con una battuta di scherzo ma decisamente sembrava che quella sera tutta la gioia di vivere i nostri anni si fosse per qualche motivo spenta.
Ricordo che ad un tratto la macchina si fermò e si spensero i fari. Cercai di riavviare il motore ma inutilmente. La prima cosa che pensai fu quella di essere rimasto senza benzina lontano dai centri abitati e nei guai, poi mi accorsi che anche le luci e il motorino di avviamento non funzionavano.
Non era un problema di benzina ma qualcos’altro e per questo la macchina non voleva più ripartire. Ricordai allora che il vecchio “rincitrullito” di Piero, il proprietario della masseria, aveva fatto il pieno di benzina senza aver adoperato per alcuna ragione la Balilla. Tutto sembrava in ordine ma il “macinino” non voleva saperne di ripartire.
Imprecai e stessa cosa fecero i miei amici.
Scesi dall’auto, sbattendo il cappello per terra dalla rabbia, scalciando la polvere e sentii le voci dei miei amici preoccupati per quel contrattempo. Poi aprirono le porte, scesero giù dalla macchina passeggiando nervosamente, prendendo a calci le ruote. Si leggeva nelle loro facce e nelle loro voci sorpresa e rabbia. Fu a quel punto che sentii un sibilo nell’aria, anche i miei amici lo sentirono perché cercarono nell’aria, girandosi, il motivo di quel suono. Il sibilo si fece più forte, sempre più forte e sembrava provenisse da tutte le direzioni. Eravamo incuriositi e disorientati. Fu un attimo e vidi nel cielo delle luci come quelle di un aereo o di un elicottero che sembrava volesse atterrare. Cosa strana però, quelle luci erano diverse da ogni altro mezzo conosciuto - pensai - e la sagoma nera come il cielo era ancora più inquietante. Il veivolo appariva sempre più distinto nella sua forma, perché prossimo all’atterraggio.
Notai - così come i miei amici - la sagoma particolare, a semicerchio, librarsi leggera, compiere manovre inconsuete mai osservate, anche per un elicottero. Non aveva rotore nella parte superiore della fusoliera, non faceva rumore se non quello strano sibilo e sembrava un prototipo o un mezzo di nazionalità sconosciuta. Atterrò a una distanza di sicurezza come se ci avesse visto dall’alto, evidentemente, con fare amichevole. Stupore, curiosità mi inchiodarono lì davanti a osservarlo e i miei amici ebbero le stesse sensazioni. Restammo zitti a fissare imbambolati quell’oggetto.
Che cos’era? - ci chiedemmo - quale poteva essere la sua nazionalità? Tedesco? Italiano? Si trattava di un nuovo velivolo non pubblicizzato dalla propaganda di regime? O piuttosto si trattava di una operazione segretissima? Era davanti a noi, reale, e quindi doveva per forza appartenere a un esercito. Non era di eccezionali dimensioni. di colore scuro, di un metallo strano, mai osservato. Pensammo che fosse anomalo quell’atterraggio, così fuori dal centro abitato e ancora più strana la missione. Troppo piccolo per sbarchi massicci di soldati e di armi, troppo strano nella forma... Che cosa stava a fare lì?
Chissà perché mi vennero in testa gli americani... decisamente mi trovavo fuori strada.
Gilda timidamente ipotizzò: «Forse è un mezzo di soccorso.»
«Un mezzo di soccorso?» ripetei io incredulo. «Ma non è possibile, qui non ci sono feriti da trasportare... oppure il pilota ha preso una sbornia e ha sbagliato la destinazione?»
La “cosa”, perché più tardi così la chiamammo quando ci fu chiara la situazione, atterrò silenziosamente. Notai un particolare insolito: non aveva ruote sui tre trespoli (o piedi) ma cuscinetti che ammortizzavano l’assetto sul terreno. Il sibilo cessò e subito dopo si aprì un portellone sulla parte inferiore della fusoliera. Sulla parte interna del portellone che fungeva da scala e che era ribaltato sul terreno, c’erano alcuni rilievi metallici come piccoli gradini che frenavano la pendenza. All’interno dell’aeromobile, una luce accecante. Notai due sagome piuttosto massicce e alte che uscivano, scendendo le scale lentamente. A questo punto la luce interna del veivolo si spense e così le sagome che vedevamo diventarono sfumate nel buio della sera. Ma c’era qualcosa di strano e non riuscivamo a capire cosa perché notai - e forse lo notarono anche i miei amici - che quei tipi che pensavamo dei soldati chissà di quale nazionalità, erano ben altro. Le gambe, i piedi e soprattutto le mani, erano strani. La nostra attenzione si concentrò sui piedi di questi tipi e sulle mani anomale. Le estremità avevano talloni troppo lunghi rispetto al normale e la parte anteriore stretta e con solo tre dita. Le mani stringevano dei bastoni metallici ed erano non umane perché smisuratamente lunghe.
Un grido di terrore mi uscì dalla gola: «Via, via, scappiamo!»
Ma le nostre urla, la nostra reazione tardiva alla fuga, non bastarono a salvarci. Sentii un forte dolore alla testa, improvviso, intollerabile, con la conseguente perdita del senso di equilibrio.
Così caddi sul terreno e mentre cadevo vidi anche i miei amici afflosciarsi per terra e torcersi come in preda ad atroci dolori. Persi i sensi. Non so esattamente quanto tempo rimasi in stato di incoscienza, ricordo che quando aprii gli occhi vidi le immagini che correvano davanti a me da destra a sinistra, per poi, dopo qualche momento, rallentare fino a fermarsi. Ricordai l’accaduto e allora mi prese un senso di terrore senza limiti, sentii il battito accelerato del mio cuore come impazzito. Cercai disperatamente di vedere i miei compagni ed essi erano là, ancora semi-svenuti.
Cercai di urlare ma non ci riuscii e mi sorpresi di essere afono. I miei occhi dilatati dal terrore vedevano qualcosa di mostruoso che neppure i miei peggiori incubi avrebbero visto. Cercai di riordinare le idee; mi trovavo in una aeronave il cui abitacolo era fortemente illuminato. C’erano tanti congegni strani, comandi che vagamente somigliavano a quelli di una cabina di aereo o a quella di un grosso mezzo navale. Ero legato con dei braccioli ai lati di un materassino imbottito e verticale, avevo uno scafandro trasparente sulla testa e tanti tubicini colorati all’altezza della bocca che comunicavano con un rilievo metallico e tondeggiante. Non potevo muovermi ed ero perfettamente cosciente della situazione. Al mio fianco Mario e Gilda anch’essi legati e impotenti, privi di sensi, nella mia stessa condizione. Non c’erano sedili per l’equipaggio del mezzo aereo, solo due sagome scure intente a incomprensibili manovre di pilotaggio. C’erano dei vetri alle pareti, abbrunati, che non mi consentivano una visuale esterna al veivolo. Eravamo in movimento.
Mi trovavo su quello strano veivolo e mi resi conto che la destinazione non era di questo mondo. Osservai meglio i due piloti dell’aeromobile e un senso di abissale terrore mi prese e mi fece rabbrividire. Erano esseri mostruosi, indossavano un’armatura o una tuta, i volti erano celati da uno scafandro o da una maschera, integrale e... non avevano niente di umano. Notai i particolari del volto appena abbozzati. Mancavano gli occhi, il naso e la bocca. Avevano dei piccoli fori o fenditure. Non avevano orecchie e al loro posto soltanto piccoli rilievi retinati.
Si muovevano lentamente e parlavano tra di loro in una lingua incomprensibile. Cercai di indovinare cosa si celasse dietro quella loro maschera e... rabbrividii dal terrore. Dove ci stavano portando? Mi chiesi il motivo di quel rapimento e conclusi che esso non prometteva niente di buono. Esperimenti? Cannibalismo? Schiavismo? Questo pensai visto la bio-diversità dei soggetti, della loro provenienza e della loro tecnologia. La mia vita e quella dei miei amici erano nelle mani di quei mostri. Cercai di riordinare le idee, la cosa non era facile. La destinazione non era di questa Terra. Non avremmo più rivisto il nostro mondo. Lo sconforto si impadronì di me ma nonostante i cupi pensieri non riuscii a piangere. Continuai a fissare i miei amici, i quali dormivano a causa di una qualche sostanza ingerita o per il trauma subito.
Casualmente diedi un’occhiata al mio orologio da polso e mi accorsi con sorpresa che si era guastato. Le lancette erano compietamente saltate. Nonostante questo, forse per incredulità, lo portai all’orecchio (sentivo i suoni anche con quello scafandro sulla testa) ' ma non udii nulla. Scuotendolo, sentii dal rumore prodotto che tutto il meccanismo era esploso per cause sconosciute. Uno dei piloti del veivolo, accortosi dei miei movimenti, si avvicinò per slacciarmi i polsi e togliermi lo scafandro con i tubicini. Gli sentii dire qualcosa ma non capii la lingua. Non appena fui liberato da quello scafandro ingombrante, scoprii respirando che in quel veivolo c’era aria ma la forte tensione nervosa mi tradì e caddi sul pavimento lentamente come un sacco vuoto, privo di forze.
Non appena mi ripresi, cercai di tranquillizzarmi ma nonostante questo non potei fare a meno di rannicchiarmi in un angolo come un bambino, spaventato. Rimasi in quella posizione, immobile, per un tempo che a me parve infinito, osservai attentamente l’interno dell’astronave e i suoi occupanti, cercai di darmi un contegno razionalizzando le mie azioni e i miei pensieri. Mi ponevo lentamente delle domande a cui non sapevo dare risposte, occorreva che sapessi qualcosa sul mio destino e quello dei miei compagni.
Cercando di vincere la mia repulsione verso i piloti del veivolo rivolsi la parola a uno di essi e mi accorsi così quanto terrore avevo dentro perché la mia voce mi sembrò un balbettio goffo e titubante.
«Dove ci portate?»
L’essere alieno, guardandomi, pronunciò qualcosa di incomprensibile seguito con un intervallo da una frase in traduzione ma dalla tonalità metallica e, al tempo stesso, glaciale.
«Silenzio, non devi disturbare!»
Capii l’ostilità di questi e mi rassegnai al silenzio ma cominciai a pensare e la prima cosa che mi venne in mente fu che l’alieno possedeva di certo un’apparecchiatura di traduzione dei linguaggi.
Pensai ancora alla tecnologia in possesso e ne dedussi un certo grado di civiltà. Questa conclusione mi portò ancora a un tipo di ragionamento indiretto.
Forse non sono esseri sanguinari.’ Un nuovo pensiero mi balenò nella mente e così cominciai a sviluppare una serie di ipotesi su di loro.
Il primo interrogativo era in relazione all’astronave. Era troppo piccola per lunghi viaggi, quindi il luogo della loro provenienza non doveva essere molto distante dalla Terra. Più tardi mi resi conto come le mie argomentazioni fossero sbagliate e del perché di questo.
Non sapevo molto di scienza, il mio grado di istruzione riguardava la natura dei terreni, i fertilizzanti, gli antiparassitari e le coltivazioni. ‘Il Sistema Solare è immenso’ pensavo, quindi il viaggio era impossibile... e allora, a quale pianeta eravamo diretti?
Valutai l’ipotesi di una ribellione e del dirottamento dell’astronave ma la scartai perché era un’idea folle, senza speranza. Anche a riunire le nostre povere forze io, Mario e Gilda non avremmo potuto pilotare e invertire la rotta verso la Terra perché un’astronave non è una macchina o un trattore. Quei mostri ci avevano rapiti per scopi che ignoravamo, di certo non avremmo più rivisto la Terra. Ma dove eravamo? Impossibile stabilirlo.
I miei amici ripresero conoscenza e io li vidi atterriti, mostravano segni di crisi respiratoria, così intervenne l’alieno che staccò l’apparecchiatura. Ancora più terrorizzati per la sua vicinanza (e lo vedevo dai loro occhi e dal loro pianto disperato) i poveretti si raggomitolarono in un angolo del pavimento dell’astronave e lì rimasero nonostante cercassi di tranquillizzarli. I due alieni parlavano tra di loro nella loro lingua attenti ai comandi e non sembravano risentissero delle nostre sofferenze. Andavano avanti e indietro senza stancarsi un po’. Un fatto curioso: non c’erano sedili per i due alieni e questo particolare mi lasciò veramente stupito.
Non riuscimmo ad avere un'idea della durata della nostra prigionia, restammo seduti per terra a lungo.
Dopo chissà quanto tempo di immobilità sentii un formicolio alle braccia, alle mani e alle gambe e così, per riattivare la circolazione del sangue, gli alieni ci videro battere le mani, scalciare. Evidentemente era già noto questo comportamento umano perché vennero verso di noi.
«Siete stanchi? Volete del “carburante” per il vostro organismo?» disse uno di essi traducendo dalla lingua aliena.
Ci guardammo guardinghi. Non sapevamo cosa rispondere. Capimmo il significato della parola “carburante” anche se questo termine ci sembrò non appropriato. Accettammo a malincuore dell’acqua e del cibo che consisteva in una poltiglia di colore verde e dal gusto dolciastro.
«È sintetico» dissero con riferimento al cibo «ma per voi biocompatibile.» Cambiando discorso, come per rassicurarci aggiunsero: «Siamo vicini alla meta ormai...»
Vicino alla meta, ripetei mentalmente ma non riuscivo a capire il significato che loro davano a quelle parole. Un pianeta? Ma quale? Le poche nozioni di astronomia imparate a scuola mi informavano di pianeti a noi vicini inospitali. Il nostro Sistema Solare contava soltanto un solo luogo adatto alla vita, la Terra, tutto il resto era una somma di mondi infuocati, sterili, ghiacciati e gassosi, luoghi senza vita. E poi c’era da considerare la grande distanza tra un mondo e un altro. Un abisso di tempo, un viaggio senza fine. Impossibile esplorare tutto il Sistema Solare. La meta, ma quale meta, mi ripetevo e sentivo in me un vortice di pensieri che mi stordivano.
Con nostra grande sorpresa gli alieni schiacciarono dei bottoni e le pareti interne dell’astronave si ritirarono rivelando un panorama che toglieva il respiro. Dai vetri, fuori era tutto nero come l’inchiostro, un abisso di vuoto siderale che dava le vertigini. Era evidente che i piloti manovrassero con sistemi strumentali e non a vista. L’astronave rallentò fino a fermarsi. Dai finestrini apparvero le sagome gigantesche di altre astronavi dalla forma aerodinamica, tutte illuminate. Erano tanto grandi da lasciare imbambolati, come e più grandi delle città terrestri. Erano due e, nelle loro vicinanze, sfrecciavano mezzi spaziali di ridotte dimensioni simili nella forma a quella in cui eravamo a bordo che entravano tutti nella pancia di quelle mostruosità dello spazio. Le più grandi ipotizzai essere come le astronavi madre in grado di viaggiare negli spazi siderali e quelle più piccole, navette intente in operazioni che ricordavano quelle effettuate dalle scialuppe di un grosso mezzo navale. Pensai questo associandolo ai mezzi navali in uso nella guerra mondiale che ci eravamo lasciati sulla Terra.
«Quelle sono le astronavi madri?» balbettai rivolgendomi ai piloti e indicandole con il dito.
Uno di essi che sembrava il capo e che sempre mi aveva rivolto la parola, confermò con la sua voce metallica e priva di emozioni: «Sono le nostre Ammiraglie,»
La nostra navetta si introdusse lentamente nel ventre gigantesco dell’Ammiraglia e quando i piloti spensero i motori notai che c’erano altre navette, da poco atterrate, come la nostra e poi un intero esercito di alieni armati di bastoni metallici; alcuni di essi volavano su minuscoli aeromobili muniti di pedana e di un manubrio simile a quello di un monopattino. Non erano veloci ma agili nei loro spostamenti. Erano tutti lì per darci il benvenuto?
«Siamo prigionieri, forse schiavi o carne da macello» bisbigliai ai miei amici che, a guardarli, sembravano più bianchi delle bianche lenzuola. Fu grande la nostra sorpresa quando scoprimmo che c’erano altri prigionieri come noi, terrestri, i quali erano spintonati rudemente da quei mostri con l’armatura.
«Non siamo soli» fu il nostro laconico commento e poi la nostra attenzione cadde su quei disgraziati. Nella quantità, variamente vestita forse ad indicare etnie diverse, notammo anche delle donne, insolitamente giovani come la maggioranza degli uomini. Qua e là notammo qualche soggetto dalla capigliatura brizzolata e con qualche ruga e questo ci fece pensare che gli alieni catturassero le loro prede con una strategia mista, a volte mirata, a volte casuale.
«Che ne sarà di noi?» piagnucolò Gilda spintonata e invitata a raggiungere un folto gruppo di terrestri, forse verso qualche prigione.
«Dobbiamo cercare di stare insieme noi tre, di non disperderci, questo per rendere meno penoso il nostro destino» disse con voce bassa Mario cercando un accordo comune.
Ci trovammo tutti riuniti in una grande stanza poco illuminata da pannelli di pietra fosforescente; c’erano dei buchi sul pavimento, forse per l’evacuazione degli escrementi, cuccette nere imbottite, in bell’ordine, e pannelli a muro con sportelli, luci e pulsanti colorati. La loro funzione più tardi ci fu nota. Notammo che all’ingresso non c’erano cancelli ma piccole luci pulsanti poste sul pavimento all’entrata e questo ci fu presto spiegato. Erano degli smaterializzatori di materia organica. In parole povere: la fuga non era consentita, chi osava pagava con la propria vita l’audacia o l’incoscienza del suo gesto.
Eravamo belli e fritti.
Ci scambiammo informazioni con non poche difficoltà. Infatti tutti quanti, meno una percentuale esigua dei presenti, era di etnia diversa. Diversa etnia significava diverso linguaggio. Una moderna torre di Babele siderale. Così il dialogo diventava un vero problema.
Sempre più ci assillava l’interrogativo del perché di questo rapimento di massa, sentivamo in ogni istante l’angoscia per la perduta libertà, dell’abisso che ormai ci separava dalla nostra cara, vecchia Terra, per i perduti affetti e interessi, per gli stili di vita individuali. Era come morire o vivere in un limbo dove non c’era più confine tra il sentirsi vivi o sentirsi spettri vaganti in una esistenza sfumata, eterea, senza più passato e senza più futuro. Una condizione questa che ci lasciava stremati, ci svuotava da ogni interesse alla vita. Gli occhi lucidi, lo sguardo spento, ci guardavamo cercando in qualcuno qualche traccia di vitalità. Dopo aver mangiato ci prese una strana sonnolenza. Non riuscivamo a tenere gli occhi aperti e presto ci rendemmo conto di avere assunto un narcotico. Ci addormentammo profondamente. Difficile dire del tempo trascorso, forse ore, chissà quante. Quando ci svegliammo gli alieni erano tra di noi con i loro bastoni metallici. Più erano vicini più sentivamo un senso di repulsione, come specie diversa, incompatibile. Ci invitarono ad alzarci con fare brusco poi - e per noi fu una sorpresa - ci informarono sul viaggio. Dunque avevano un po’ di considerazione, non ci vedevano come animali. Un alieno, forse un capo - e lo riconobbi tra tanti per il distintivo particolare sull’armatura -, lo stesso che ci aveva rapiti, ci parlò traducendo in molte lingue terrestri. Il che voleva dire che ci conoscevano da tempo e che avevano avuto modo di studiare i nostri linguaggi.